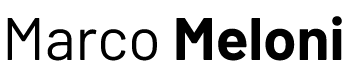Ddl Gelmini, un mostro chiamato riforma

Sciolgo volentieri il dubbio di Tommaso Nannicini sul giudizio del Pd in merito al ddl Gelmini. Esso incide con forza nella direzione sbagliata e rientra sicuramente nel caso c) della sua tavola dei giudizi. A parole promette valutazione, nei fatti produce solo burocrazia.
È un tipico esempio del format berlusconiano delle leggi-manifesto che in 15 anni hanno prodotto ottimi slogan mediatici e aggravato i problemi, come è sotto gli occhi di tutti. Il testo è composto di 171 norme, che diventeranno più di 500 con le deleghe e richiederanno 1000 regolamenti attuativi e ben 47 decreti del governo. I professori passeranno le loro giornate a scrivere regolamenti e a interpretare le nuove norme, d’altronde non avendo soldi per la ricerca potranno dedicarsi a tempo pieno alla burocrazia. Le università saranno bloccate per almeno due anni a metabolizzare l’indigestione legislativa. Anche la legge Moratti venne presentata come la riforma epocale della meritocrazia. Le degenerazioni dei corsi e delle sedi sono cominciate proprio mentre si approvava quel provvedimento, passato come acqua fresca sui difetti dell’accademia. E certo neppure il nostro governo di centrosinistra riuscì a cambiare rotta. Può reggere un sistema che nell’arco di pochi anni assiste al fallimento di due riforme epocali? Si può star male per assenza di riforme, ma si può morire anche per troppe riforme sbagliate.
Basterebbe questo per dimostrare che il testo è irricevibile. In qualsiasi paese europeo il ministro che avesse proposto 500 norme sarebbe stato rinviato nel suo ufficio a studiare meglio il problema. Solo in un paese segnato dalla mentalità dell’Azzeccagarbugli può succedere che si discuta di un mostro burocratico chiamandolo riforma. Parlare di valutazione e appesantire le norme è come “buscar el levante por el ponente”. Cosa che riuscì una volta a un grande italiano, ma il caso attuale è diverso. Infatti, se si impone per legge che tutti gli atenei debbano fare le stesse cose allo stesso modo – a prescindere dalla dimensione, dalle discipline e dal mix tra ricerca e didattica – rimane ben poco da valutare. La vera riforma, al contrario, avrebbe dovuto cancellare leggi esistenti, promuovere le innovazioni e le differenze, sollecitare il confronto tra diversi modelli organizzativi degli atenei.
Tutte le proposte del Pd andavano nella direzione di una legislazione mite che lascia fare e affida la regolazione alla verifica dei risultati, e su questa strada certo si potrà fare anche meglio in futuro. Esse tendevano anche a cambiare l’agenda per mettere al centro i veri problemi: la ricerca universitaria ridotta al lumicino, l’organizzazione della didattica ancora in mezzo al guado tra esperienze positive e fallimenti evidenti, il diritto allo studio molto al di sotto degli standard europei e degli stessi obiettivi costituzionali dell’articolo 34.
Mi dispiace che Nannicini non abbia avuto la pazienza di leggere i nostri emendamenti perché, ne sono certo, li avrebbe apprezzati come buone notizie. Le sue proposte, infatti, coincidono con quelle del Pd. Sulla tenure track volevamo «rendere equo lo scambio», per usare le sue parole, tra la temporaneità del contratto e la certezza dell’assunzione nel caso di raggiungimento dei requisiti di produttività scientifica da parte del ricercatore. Ci sono oggi circa 50 mila giovani che fanno ricerca o insegnano con contratti temporanei e con stipendi poco dignitosi. Il tabù del ricercatore a vita è stato rotto da almeno dieci anni, ma in modo selvaggio. Il ddl doveva stabilire regole credibili di accesso secondo il merito e invece di fatto conferma la giungla esistente.
Alla valutazione abbiamo proposto di riservare una quota del 20% del Fondo per l’università. La Gelmini ha annunciato sulla stampa una quota del 10%, per poi concordare con i rettori una banda di oscillazione del 3%, ottenendo in cambio il pieno consenso alla legge. Il suo mandato ministeriale si concluderà nel 2013 (?) senza aver fornito neppure un numero sulla produttività scientifica degli atenei. L’Anvur è stata approvata dal governo Prodi e in due anni e mezzo la ministra non è stata capace di metterla in funzione, ma nel frattempo ha bloccato anche l’organismo ministeriale di valutazione, il Civr, che pure aveva ben operato in passato. In mancanza di dati si utilizzano quelli di dieci anni fa, ed è meglio non farlo sapere all’estero perché ci prenderebbero per matti. Il fondo per il merito è stato istituito nel 2004, non è una sua invenzione, e non ha mai impensierito nessuno perché appunto non è ripartito sulla base di dati competitivi. Infine, in questi giorni si appresta a trasformare il Cepu in università non statale con lo stesso rango della Bocconi, abbassando paurosamente l’asticella della qualità del sistema universitario italiano. E pare che la vicenda non sia estranea ai mercanteggiamenti che hanno tenuto in vita il governo.
Ciò nonostante una parte dell’accademia ha creduto in buona fede alle balle governative sulla meritocrazia. È il segno del conformismo diffuso nella discussione pubblica nel nostro paese, soprattutto nella cultura economica. Se fa difetto, almeno in parte, proprio lo spirito critico che è un fondamento dell’università, allora la riforma è davvero necessaria, ma dovrebbe riguardare la funzione culturale di quell’istituzione, prima delle sue norme amministrative.
Infine, una risposta sui simboli. Bersani è andato sui tetti per ascoltare le proposte dei ricercatori che sono molto serie – basta leggere i loro documenti – e sempre coerenti con la regola del merito. Da ministro quando fece le liberalizzazioni subì la protesta di piazza a volte sguaiata e spesso fomentata dagli attuali ministri Tremonti e La Russa. Una coerenza del segretario si vede in questo confronto. C’è bisogno di meno corporazioni e più ricerca scientifica nel futuro italiano.