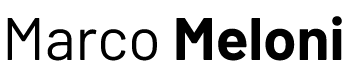Il Manifesto – Vado via, ma solo quando lo dico io
Tratto da “Il Manifesto” – 6 marzo 2018
Le dimissioni che Matteo Renzi rassegna nella sala del Nazareno poco dopo le 18 sono «dimissioni verissime», come spiegherà più tardi Lorenzo Guerini. Ma postdatate: «È ovvio che lasci la guida del Pd dopo questo risultato, e ho già chiesto al presidente Orfini di convocare una assemblea nazionale per aprire una fase congressuale», spiega, ma sia chiaro: solo «al termine della fase di insediamento del parlamento e del nuovo governo».
LA CONFERENZA STAMPA SLITTA di più di un’ora. Per tutta la giornata dal Nazareno filtrano voci di una «gestione collegiale», di un «reggente» che chiuda quanto prima la stagione di Renzi. Ma il segretario resiste e sfida tutto il partito, tranne i pochi fedelissimi rimasti.
Nella conferenza stampa – one man show, alla fine non saranno ammesse domande, come fosse un Di Maio qualsiasi – Renzi ammette la sconfitta – e mancherebbe, con quel numero desolante, quota 18,7. Ammette di aver fatto qualche «errore». Ma alla fine scarica la colpa di tutto sugli altri: Mattarella, Gentiloni, il suo partito e il popolo italiano. Loro, ovvero lui, ha fatto «un lavoro strepitoso», ma poi «abbiamo compiuto un errore: occorreva votare in una delle due finestre del 2017 durante le elezioni francesi e tedesche. L’agenda, come accaduto a marzo 2017 in Olanda, sarebbe stata sull’appartenenza europea. Ma non abbiamo colto quell’opportunità». Insomma colpa del Colle che ha frenato la sua corsa al voto dopo la sconfitta referendaria; colpa di tutti i dem che «non hanno capito», di Gentiloni fra loro.
ORA SE NE VA. O meglio se ne andrà: solo dopo che si sarà assicurato che il Pd rispetti le promesse della campagna elettorale: «No inciuci, no caminetti, no estremismi». Tradotto: niente governo con le destre, niente ritorni alle concertazioni interne, nessun cedimento alle sirene dei 5 stelle. Che ora, vittoriosi ma scarsi di voti per governare, blandiscono i fin qui disprezzati dem. Anche se il Colle dovesse chiederlo. Fra i sospettati di intelligenza con il nemico, neanche a dirlo, c’è Dario Franceschini: i renziani gli attribuiscono la tentazione di fare il presidente della camera con i voti dei 5 stelle. In cambio di un appoggio al governo.
«NON FAREMO MAI ACCORDI. Mostrino il loro valore se ne sono capaci», sfida Renzi. È un avviso ai 5 stelle, ma anche ai suoi. Dopo si aprirà il congresso, «un confronto vero dentro il Pd su ciò che è accaduto in questa campagna elettorale, in questi mesi, in questi anni», ma che sia «un congresso serio e risolutivo, non uno che si apre e non finisce mai, ma uno che permetta alla leadership di fare quello per cui è stato eletto». Tradotto: avevo vinto ma non mi hanno fatto lavorare.
HA IN MENTE DI RILANCIARSI? I suoi giurano di no. Lui assicura che «terminata la fase di insediamento del governo e del parlamento farò un lavoro che mi affascina: il senatore semplice», eletto «a Firenze, Scandicci, Signa, Lastra a Signa e Impruneta», «si riparte dal basso», «restituiamo le chiavi di una casa tenuta bene e molto più in ordine», dice, riferendosi al governo. Ma anche dando per buona l’affermazione, potrebbe dirsi altrettanto delle condizioni in cui lascia il partito? Non sembra. Non solo per quel disastroso 18,7 per cento a cui ha ridotto il Pd, ma anche a giudicare dalle reazioni da trincea che si scatenano all’interno del partito, per la prima volta dalla fuoriuscita dei bersaniani.
DOPO GIORNI DI MUTISMO Andrea Orlando, leader dell’opposizione, lo accusa di essere affetto da sindrome da «in un bunker»: «Di fronte alla sconfitta più grave della storia della sinistra italiana del dopoguerra mi sarei aspettato una piena assunzione di responsabilità». Invece «siamo alla ormai consueta elencazione di alibi e all’individuazione di responsabilità esterne». Ora, con l’annuncio di dimissioni postdatate «Renzi definisce la linea dei prossimi cruciali mesi e il percorso congressuale. Insomma, lo stesso gruppo dirigente che ci ha condotto alla sconfitta oggi si riserva il compito di affrontare, senza nessuna autocritica, questa travagliatissima fase per il Pd e per il paese». La minoranza si è data appuntamento a Roma domani. A Orlando fanno eco gli ex dalemiani Gianni Cuperlo, Anna Finocchiaro, Nicola Latorre, tutti esclusi eccellenti dalle liste. Come del resto il lettiano Marco Meloni, che attacca: «Quelle di Renzi sono nuove dimissioni fake, come quelle post-referendum del 2016. Un cinico tentativo di avvelenare i pozzi, che deve essergli impedito». Anche il gentiloniano Luigi Zanda affonda: «In un momento in cui al Pd servirebbe il massimo di quella collegialità che è l’esatto opposto dei ccaminetti, annunciare le dimissioni e insieme rinviarne l’operatività è impossibile da spiegare», «quando Veltroni e Bersani si sono dimessi lo hanno fatto e basta».
ORLANDO CHIEDE la convocazione di una direzione. Che comunque è già in agenda. «Nessuna dilazione, le dimissioni di Renzi sono verissime», replica Lorenzo Guerini, «Il tema centrale è un punto politico: il Pd è all’opposizione, in coerenza con quanto detto in campagna elettorale da tutto il Pd. E nessuna gestione solitaria dei prossimi passaggi: lunedì prossimo faremo direzione e quello sarà il luogo e il momento per aprire una riflessione seria e responsabile sui risultati e sui prossimi passaggi». L’assemblea nazionale è convocata per il 15 aprile. Ma è una data lontana: «Da qui a metà aprile passerà molta acqua sotto i ponti», spiegano al Nazareno. Prima dovranno essere scelti i presidenti delle camere, la legislatura potrebbe iniziare. Poi l’assemblea potrà eleggere un nuovo segretario per arrivare a congresso, modello Epifani 2013. Oppure, se non elegge nessuno, per statuto sarà il presidente del partito Orfini a gestire la fase congressuale.
[Daniela Preziosi]