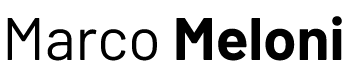Il mio voto sul “jobs act”
Anche per rispondere alla domanda che molti amici mi pongono, credo sia giusto chiarire il mio voto (e le sue ragioni) sul “jobs act”.
Ho votato a favore per due motivi principali: ritengo che scelte di voto difformi da quelle deliberate dal gruppo parlamentare debbano costituire un’assoluta eccezione, limitata ai casi nei quali siano in gioco questioni democratiche essenziali (per questo motivo non partecipai al voto finale sulla legge elettorale, ad esempio); ritengo le norme introdotte da questo provvedimento non rientrino in questa categoria. Si tratta, infatti, di una delega che al limite può essere criticata per la sua genericità (i decreti delegati potranno ben disegnare le esigenze di tutela dei lavoratori, dunque) e per il rischio che l’aggiornamento del contenuto dell’articolo 18, anziché ridurli, aumenti l’incertezza normativa e dunque i contenziosi (lo ha fatto rilevare Tito Boeri), che rappresentano il maggior disincentivo all’attrazione di investimenti. Nel complesso è però innegabile che il provvedimento costituisca un importante passo in avanti verso la costruzione di un mercato del lavoro più moderno e di un welfare universalistico. E’ chiaro che, perché questo disegno sia completato e corrisponda all’obiettivo di incrementare l’occupazione, la“buona” occupazione, occorrono risorse importanti rivolte a una serie di obiettivi: sostenere l’indennità di disoccupazione universale; sostenere politiche industriali capaci di rilanciare il nostro sistema produttivo (questo fu il “jobs act” dell’amministrazione Obama); modernizzare il sistema dell’istruzione e potenziare la transizione istruzione-lavoro. Risorse e riforme: qui sta il problema, al momento con pochissime tracce di soluzione.
In ogni caso, al contrario di quanto molti sostengono, le riforme della legislazione sul lavoro dovrebbero essere adottate con le minori contrapposizioni possibili e con consensi amplissimi: inItalia – e solo in Italia – le divisioni su questo tema hanno causato conflitti sociali asprissimi che sono stati cinicamente sfruttati dalla criminalità terroristica per prolungare fino a pochi anni fa la spirale di lutti e morte(ricordiamo gli assassini di due studiosi riformisti come Massimo D’Antona e Marco Biagi, e la vita tuttora sotto scorta di molti giuristi ed economisti impegnati sulle tematiche del lavoro, da ultimo il nostro Filippo Taddei, al quale esprimo la mia solidarietà).
Concludo con alcune sintetiche opinioni sul significato politico della “questione lavoro”. Anzitutto non penso che il“lavoro” come totem astratto costituisca il tratto fondante del PartitoDemocratico, che invece nasce per migliorare le condizioni di benessere e di uguaglianza sostanziale dei cittadini (in sintesi: parità di condizioni di partenza e una cultura dei doveri, insieme al libero mercato ben regolato,consentono di realizzare l’articolo 3 della Costituzione e per questa via di inverare la Repubblica “fondata sul lavoro” dell’articolo 1) e penso che uno degli errori di fondo della segreteria Bersani (ne facevo parte, non ero d’accordo su questa impostazione e l’ho detto pubblicamente, ma mi assumo la mia quota di responsabilità) sia stato assecondare una tale lettura astratta e antistorica della nostra cultura politica, impedendoci di parlare all’intera società e di posizionarci al centro dello scenario politico, come deve fare un partito progressista che abbia l’ambizione di governare col consenso maggioritario degli elettori. In secondo luogo il Partito Democratico nasce anche con la funzione di unire culture politiche che, anche per ragioni storiche, leggono in maniera differente il conflitto sociale e dunque le modalità per giungere a una maggiore giustizia sociale. Infine, e di conseguenza, così come non ho condiviso la scelta dei deputati del Pd che hanno deciso di non votare questo provvedimento, ritengo sia stato altrettanto sbagliato il modo con il quale il presidente del Consiglio dei ministri ne ha impostato il percorso, basandolo sin da principio su una logica di contrapposizione “violenta” del tutto inappropriata, con conseguenze evidenti (e probabilmente volute) sulla stessa natura del Partito Democratico quale soggetto politico progressista e riformatore, erede diretto dell’Ulivo, il cui primo governo adottò per primo riforme sul lavoro di grande impatto con l’azione da ministro di Tiziano Treu. La “violenza” di cui abbiamo bisogno, casomai, ha il nome della franchezza con la quale si dovrebbe dire al Paese una verità ineludibile: evitiamo di disperdere in mille rivoli le risorse, evitiamo gli interventi elettoralistici e siamo severi con la revisione della spesa, e destiniamo 20 miliardi all’anno a sconfiggere il flagello della disoccupazione e della decrescita infelice: sostegno allo sviluppo produttivo, un vero welfare universalistico, istruzione scolastica e universitaria all’altezza degli altri Paesi europei.
Siamo ancora in tempo, abbiamo i prossimi mesi per decidere, insieme, cosa sarà il “jobs act”. E dobbiamo deciderlo con un approccio temo non troppo popolare in questa convulsa stagione, ma totalmente differente da quello finora adottato dal governo:in luogo della logica della “riforma epocale”, del nemico quotidiano e del conflitto permanente, su questo come su molti altri temi dovremmo riscoprire le virtù della politica come “riforma continua”, come mediazione paziente, come motore che spinge tutti gli attori economici e sociali alla cooperazione e all’innovazione coraggiosa, in un impegno comune per l’affermazione di spazi maggiori di progresso sociale, benessere economico, libertà individuale e dignità della persona.